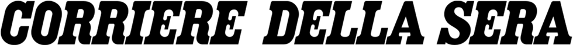Che ve ne sembra dell’America?
di Tito Barbini - Mercoledì 25 Aprile 2018 ore 14:10

Non quella del secolo scorso cui si riferiva William Saroyan, il grande scrittore americano di origine armena, in una straordinaria raccolta di racconti che aveva appunto questo titolo. Ma l’America che lascio in queste ore per tornare a casa dopo un lungo viaggio in auto da New Orleans a Chicago. Per inciso, lasciatemelo ricordare quel libro, che divorai quando uscì nel 1965 negli Oscar Mondadori al prezzo di duecento lire, con la traduzione di Elio Vittorini.
Per quella edizione l’autore scrisse una epigrafe: “Agli italiani della mia città natia, con i quali crebbi, con i quali vende i giornali, lavorai nelle vigne, studiai e giocai”. Si riferiva a Fresno, in California, dove molti italiani erano andati per lavorare nelle vigne e nei frutteti. Messicani prima del tempo, immigrati come i tanti a cui oggi noi vorremmo chiudere le porte. E con Saroyan, i tanti altri scrittori. Dos Passos, Caldwell, Steinbeck... a raccontare una terra che sapeva rapirmi anche se spietata, violenta, carica di ingiustizie.
L’America è stata un mito, un sogno, una suggestione infantile a cui resto ancora oggi affezionato. In più di cinquant’anni nessun evento è riuscito a scuotere questo mio innamoramento. Iniziò allora, con gli aiuti del Piano Marshall e le mie fantasticherie. Nei miei sogni di ragazzino c’erano sicuramente anche le praterie e gli indiani e la frontiera che mi attendeva. Il mito dell’America non svanì nemmeno più tardi, quando scelsi la Russia dei Soviet. Semmai con quest’ultima riuscì̀ a convivere, in un equilibro da funamboli.
Mito per mito, insomma, c’era l’America davanti a me: non l’America vera, ma quella di tutte le cose con cui mi ero riempito la testa. Mi sembrava di vederla, quell’America, di ascoltarla, complici tutti i film visti e rivisti al cinemino di Cortona, quello dove era possibile tifare come allo stadio, accompagnando in coro colonne sonore che ti entravano nel sangue. Via col Vento, ma più tardi anche Fragole e sangue. Ombre rosse, ma anche Zabriskie Point, che poi tra tutti mi sembrava il più americano di tutti, benché́ il regista fosse il genio nostrano, Antonioni.
L’America era la musica della West Coast, era Bob Dylan, era anche il country e il folk del profondo sud. L’America era un pollice puntato al margine di una strada che tagliava il continente e un campus dove non sapevi se avresti preferito incontrare gli studenti in sciopero di Berkeley o gli studenti fuori di testa alla John Belushi. L’America era la libertà.
Già̀, la libertà. Eppure, eppure, per gente come me, c’era questo mito e insieme l’altro mito, l’Unione Sovietica. Leggevo gli americani, ascoltavo gli americani, mi immaginavo in viaggio per l’America. Però poi tifavo URSS, e con l’URSS gli altri Paesi del socialismo stabilito. Aveva un senso? Uno solo, ma bastava: ero un comunista e il mio era un modo di essere contro. Di essere contro stando qua, ovviamente, non là. Là non ti avrebbero fatto nemmeno fiatare, ma qua, nel mondo del capitalismo realizzato, nel mio mondo di ragazzino, dichiararsi come filo-sovietico serviva a manifestarsi come eroe dei più deboli.
In ogni caso, dopo la seconda guerra mondiale, l’America (come la Russia) apriva davvero sconfinati spazi alla nostra immaginazione di ragazzi. Prima sugli schermi del cinema, poi sui libri di Faulkner, sulle note dei sassofoni o con la moda dei jeans. Non era solo l’America dei pionieri o del genocidio indiano, o degli emigranti di Ellis Island, dei grattacieli. Era un mondo che appariva ricco di opportunità̀, di fantasia, un pianeta con nuove frontiere. Tuttavia, non fu quella l’America che trovai quando nei primi anni sessanta mi capitò di visitarla, da sindaco comunista.
Prima di noi tutti però ci era andato Giuseppe Dozza, amatissimo sindaco di Bologna, quando il Comune di Bologna fu invitato al Congresso mondiale dei poteri locali. Era il 1961 e quel congresso, per dire, venne presieduto da Eisenhower. A me di quel primo viaggio restano foto bellissime. La 34th Street dall’alto dell’Empire. Il classico Brooklyn Bridge al tramonto. Le quinte pubblicitarie di Times Square. Che mondo incredibile, che rivelazione, per un ragazzo tirato su nelle assemblee di Partito.
Immagini che raccontano l’America dei bianchi e dei neri, dei grandi alberghi di lusso e degli slum più miserabili, tanto miserabili. L’America anche delle scale antincendio, all’epoca da noi sconosciute, e dei condizionatori d’aria negli ospedali. Un Paese visto, forse proprio grazie al filtro di una fotocamera, senza il pregiudizio delle ideologie.
L’ho fatta lunga per dirvi che, fino a poco tempo fa, se eri iscritto al Partito Comunista o lo eri stato nel passato, in America non entravi. Figuriamoci, poi, se eri un dirigente politico e facevi parte del Comitato centrale. Ci voleva un permesso speciale del Dipartimento di Stato e veniva concesso solo se una Istituzione culturale, quasi sempre un’ università, formulava un invito ufficiale, con tanto di programma e itinerario annesso. A quei tempi al Dipartimento di Stato c’erano mastini come Kissinger e non c’era nulla da fare: i comunisti non avrebbero conquistato l’America.
Il mio invito giunse infatti dall’ Università della Georgia. Era un invito al sindaco che aveva accolto gli studenti e i professori dei corsi d’arte e di architettura nella sua Cortona, cittadina di una Toscana culla dell’arte e del Rinascimento. Nell’invito era prevista la cerimonia per una sorta di protocollo di amicizia con il sindaco di Atlanta.
Così è capitato anche questo, nella mia vita. Diventare, a un certo punto, sindaco onorario di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti d’America. Era il 1975 e un anno prima Maynard Jackson era diventato il primo sindaco nero della Georgia. Proprio l’incontro con Jackson mi rimase impresso più di ogni altra cosa. Era alto, possente nella sua stretta di mano, con un sorriso appena celato dai massicci baffi neri. Mi accolse con grande calore. Volle sapere anche della mia attività̀ politica. Lui era un democratico progressista e veniva dire amante dal movimento di Martin Luther King.
In “Selma”, il bel film che racconta la marcia per i diritti civili, accanto a Luther King compare proprio lui, Maynard Jackson. Proprio in quegli anni si sono create le premesse per il sostegno al fascismo di Pinochet o agli squadroni della morte in Argentina o Brasile. E non molti anni prima c’era stato My Lai. Ai più, questo nome non dice niente. Eppure è a My Lai che si è consumata la strage più stupida e crudele della storia americana, o almeno dell’intero Novecento.
Tornando indietro nel tempo, in effetti, incontriamo il genocidio degli indiani e quell’alba sul fiume Sand Creek, quando il giovane colonnello Chivington ordinò il massacro. I guerrieri erano a caccia del bisonte: bambini, donne, anziani, colti nel sonno, arrossarono il fiume con il loro sangue. Impossibili non lasciarsi catturare da questo Paese che con i suoi veleni ha sempre saputo fornire anche i giusti antidoti. Di generosi entusiasmi abbiamo riempito le nostre strade, convinti di cambiare il destino del mondo. Eravamo così ingenui, a pensare che il bene e il male fossero nettamente distinti in quella lunga striscia di terra chiamata Vietnam? In quel Vietnam leggendario dove i piccoli uomini, fragili e magri, soldati e conta- dini, non si lasciavano piegare dai giganti tecnologici?
Il Vietnam vinse la sua guerra di liberazione, ma la storia non voltò pagina: ripropose in altri Paesi e altri continenti il terribile e violento quesito sulla libertà. Un concetto non divisibile e una parola che non si può spezzare: libertà. Forse la parola più importante a rimanermi, dopo che sono arrivato a capire che non esistono guerre giuste e guerre ingiuste. Eppure, conservo nel cuore il mito americano e sono indulgente e mi viene da visitare il mausoleo a Lincoln come se visitassi il luogo della libertà. Anche quando arrivai, in quel lontano 1975, ero carico di un sentimento positivo. Di più, ero grato per il mio destino, che mi stava permettendo di conoscere di persona l’America.
Quell’America che rimaneva per me, nei momenti in cui mi spogliavo della mia identità di militante comunista, il continente dove era vivo il senso della libertà e della democrazia. Il Paese al quale la storia aveva a dato il compito di salvare il mondo dalla follia nazifascista e di difenderlo dal delirio di onnipotenza dell’imperialismo giapponese. Quell’America che aveva conquistato la luna – anche se io avrei preferito lo avesse fatto Gagarin.
Quando si arriva negli Stati Uniti si pensa di essere già preparati a tutto o a quasi tutto. Cinema, televisione, mode e tendenze dell’arte. Che dire del Moma o dell’Art Institute di Chicago. Non ci sono parole per raccontare il loro splendore. Ti colpiscono subito i grattacieli di New York, la marea dei taxi gialli, la polizia a cavallo nelle strade di Manhattan e gli infiniti colori della pelle. In questo ultimo viaggio, a Chicago, ho camminato con il naso all’insù̀ come Alice nel paese delle meraviglie, talvolta inciampando nei diseredati su un letto di cartone. Gli Stati Uniti: un paese pieno di contraddizioni. Forse incomprensibile ma ancora emozionante. Ti senti tradito perché ha scelto Trump ma, nello stesso tempo, sai benissimo che saprà liberarsene e forse, chissà, sceglierà Sanders. Cosi è l’America…
Tito Barbini